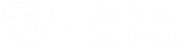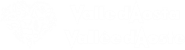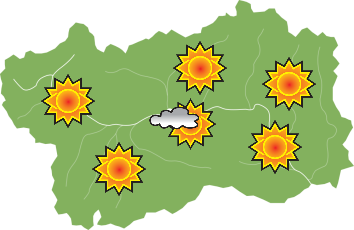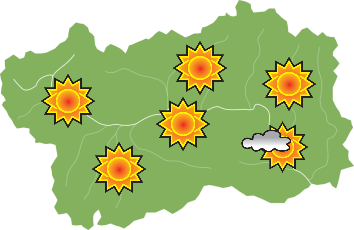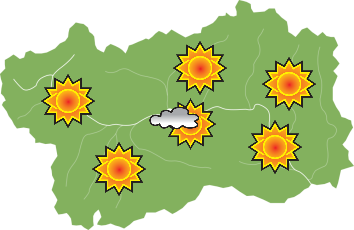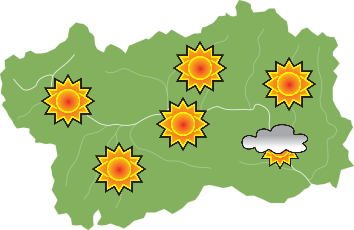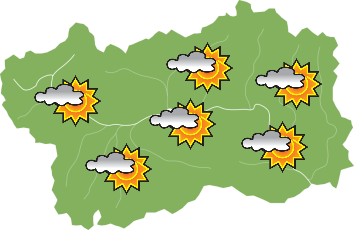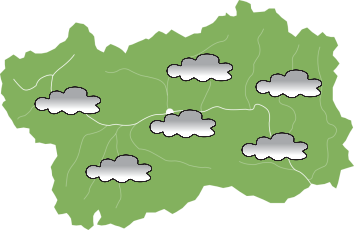Ingresso gratuito, per le mamme accompagnate dai figli, l’11 maggio 2025
Prenota e acquista i tuoi biglietti online
Uno dei più interessanti siti archeologici della preistoria in Europa ma anche un luogo dove la storia ha continuato a lasciare testimonianze anche nei secoli successivi. Vieni ad Aosta ed approfitta delle iniziative e delle visite guidate del museo e scopri tutte le novità del recente e moderno allestimento.
Il sito archeologico
L’area, riportata alla luce nel 1969, si estende per circa un ettaro e rivela uno dei più interessanti siti archeologici della preistoria in Europa: significative testimonianze di quasi cinque millenni di storia, dai momenti finali del Neolitico ai giorni nostri.
Il termine area megalitica è stato utilizzato per definire sinteticamente il ritrovamento di Aosta, che non presenta finora riscontri, all’infuori di quello, seppur parziale, con il sito di Sion, Petit-Chasseur, in Svizzera.
Per “area megalitica” si intende una porzione di terreno, più o meno estesa ma ben delimitabile, nella quale sono presenti testimonianze monumentali megalitiche multiple e di tipo diverso.
Non si tratta, infatti, di un semplice allineamento di menhir o di stele antropomorfe, oppure di una necropoli o di singole tombe dolmeniche: i ritrovamenti mostrano invece l’esistenza di un’area sacra destinata sin dall’inizio a essere sede di ricorrenti manifestazioni legate al culto e alla sepoltura.
Sono state individuate cinque fasi strutturali che, a partire dal Neolitico recente (fine del V millennio a.C.) e attraverso tutta l’Età del Rame (IV-III millennio a.C.), giunge all’Età del Bronzo (II millennio a.C.).
Configurata dapprima come un santuario all’aperto destinato al culto dei viventi, l’area assume solo negli ultimi secoli del III millennio funzioni funerarie, divenendo una necropoli privilegiata, con tombe monumentali di varia tipologia megalitica.
In ordine cronologico è possibile apprezzare: le tracce di un’aratura propiziatoria (fine V millennio a.C.) seguita dalla creazione di pozzi allineati sul cui fondo trovano posto offerte quali macine unite a resti frutti e cereali.
In un momento successivo (inizi del III millennio a.C.) si ha l’allineamento di almeno 24 pali totemici in legno orientati da Nord Est a Sud Ovest progressivamente affiancati e poi sostituiti da più di 46 imponenti stele antropomorfe, prima vera manifestazione del megalitismo in quest’area, magistrali capolavori della statuaria preistorica.
La destinazione d’uso dell’area si fa nettamente funeraria con la costruzione delle prime tombe megalitiche, probabilmente occupate da membri di eminenti famiglie della comunità, costruite totalmente fuori terra. Protagonista esemplare è la cosiddetta “Tomba 2”, eretta su un’insolita piattaforma triangolare di pietrame, utilizzata per quasi un millennio come sepoltura collettiva ospitante i resti di ben 39 individui.
Il museo
Visitare il museo comporta una discesa temporale dall’odierno alla preistoria: lungo un tragitto costellato da immagini riferite alla storia umana, le passerelle dall’ingresso del museo conducono il visitatore al livello del sito archeologico vero e proprio (a circa 6 metri sotto il livello stradale).
Si apre allo sguardo un ambiente grandioso: attraversando la dimensione del tempo, i toni delle luci colorano l’atmosfera che avvolge i reperti archeologici, il dolmen, le stele abbattute, le piattaforme, le tracce delle arature. La visita è un continuo affaccio sul sito archeologico, in una sorta di costante dialogo “interno-museo / esterno-sito”.
Spiegazioni, approfondimenti e interpretazioni sono disponibili su apparati didattici e multimediali.
Da non perdere:
- la suggestiva Rampa del Tempo arricchita da elementi tridimensionali
- la sorprendente Sala immersiva
- la Grande Sala delle Stele dove ammirare 46 stele antropomorfe ritrovate nel sito.
- La sezione dedicata alla Protostoria che illustra i grandi cambiamenti verificatisi nell’area all’inizio del II millennio a.C., quando la funzione agricola prende il sopravvento su quella funeraria: si possono osservare numerose orme umane impresse nel terreno arato ritrovate in occasione dei più recenti scavi archeologici. In questo spazio, inoltre, si apprezza il grande tumulo funerario dell’Età del Ferro (I millennio a.C.) con il suo piano di calpestio originale.
- al piano superiore protagonista è l’epoca romana declinata in due sezioni: una dedicata alla vita quotidiana in ambiente rustico, e l’altra alle necropoli scavate nel corso degli anni lungo la strada, al di sotto della chiesa parrocchiale e della scuola materna: si trovano 20 tombe connotate da corredi ricchissimi, nonché da pratiche e rituali funerari molto diversi tra loro per cronologia e tipologia.
- conclude il percorso la sezione medievale che presenta le testimonianze gravitanti intorno alla chiesetta romanica di Saint Martin.
Presenti anche un ampio spazio relax, un'area dedicata ad esposizioni temporanee e una sala conferenze di 160 posti.